Mucarà, medera o cucharo: la Serenissima dello zucchero

VENEZIA. Non soltanto il sale. La fortuna mercantile della Serenissima Repubblica era stato il frutto di un commercio prezioso. Quello dell’oro bianco ricavato dalle sue lagune. Ma Venezia era nel Quattrocento anche uno dei produttori più importanti di zucchero, che esportava in tutta Europa. Lo ha scoperto il professor Lorenzo Lazzarini, esperto di petrografia e di storia veneziana. «Il merito è tutto di Ernesto Tito Canal», dice il professore. Il compianto ispettore onorario della Soprintendenza archeologica del Veneto ha passato una vita a cercare sui fondali lagunari reperti e ceramiche. Per ricostruire attraverso quei frammenti, analizzati con il carbonio 14, la storia delle origini.
«Un giorno di tanti anni fa», ricorda il professore, «Tito era arrivato nel mio laboratorio della Casetta del prete, a San Gregorio della Salute. Aveva estratto dalla sua borsa una serie di frammenti e uno strano vaso ceramico, perfettamente conico, alto una trentina di centimetri, con un diametro alla bocca di circa venti e con l’apice forato. Provenivano dalla zona di Fusina, dove Canal si recava spesso nei giorni di bassa marea per cercare frammenti presso i resti dell’argine di intestadura. Lì c’erano ancora i resti dei cassoni lignei di colmata riempiti dai rifiuti solidi prodotti a Venezia a partire dagli anni Venti del Duecento».
Canal aveva raccolto nei decenni di ricerca migliaia di reperti testimonianza della vita quotidiana della città, dal periodo tardo medievale a fine Ottocento», ricorda il professore. «Il mistero del vaso durò parecchio tempo. Finché un giorno non mi imbattei in una illustrazione del Grevembroch, conservata alla Biblioteca Marciana, che raffigurava i “Raffinatori de zuccheri“ dove comparivano batterie di coni simili al nostro. Ecco svelato il mistero: quei recipienti servivano a raffinare lo zucchero! Una redditizia attività veneziana ai più del tutto sconosciuta». Invece rintracciabile ancora oggi nei numerosi toponimi cittadini.
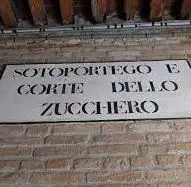
La Corte della raffineria a Cannaregio, in fondamenta della Misericordia; la calle dello Zucchero a Dorsoduro 411 e il sotoportego e la corte dello Zucchero, sempre a Dorsoduro 2365: la Corte Raffineria a San Polo 1902, la calle della Raffineria a San Polo 1907.
Dunque, Venezia importava zucchero e lo rivendeva al Nord Europa raffinato. In pani e in contenitori speciali detti “cantarelli”.«Di zucchero esistevano molteplici qualità», descrive Lazzarini nel suo saggio. Il mucarà, ritenuto il migliore, e il bambillonia, di ignota provenienza; il damaschino e il medera, che si suppone prodotti a Damasco e a Madera; il cucharo di Candia e di Cipro. E poi gli speziati come il rosato e violato, il cinciber con lo zenzero. Già nel Trecento Venezia vendeva zucchero alle città lombarde per 85 mila ducati l’anno. E alla fine del Quattrocento i raffinatori de zucchero erano così numerosi da costituire un’arte che rientrava in quella degli Spezieri de grosso. Una lavorazione che impegnava molta manodopera e produceva ricchezza. Venezia a un certo punto diventa la Capitale dello zucchero, e domina il mercato fino all’avvento della canna americana. «Una realtà che abbiamo potuto scoprire», dice Lazzarini, «grazie alle ricerche di quel grande conoscitore della laguna che era Ernesto Canal. E che speriamo di poter mostrare nel nuovo museo della città». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © La Nuova Venezia








