La Biennale: «Arti visive» nel segno della pittura
L’esposizione d’arte punta su maestri e giovani da loro ispirati. Partecipazioni nazionali di grido
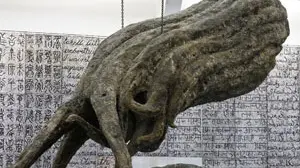
ompito d’artista è «Fare Mondi», c’è chi li fa quadri, c’è chi li fa tondi. Visto che alla Biennale Arti Visive di quest’anno troverà spazio anche la poesia, potrebbe anche essere declinato in rima il tema dell’edizione numero 53, presentata ieri a Roma nella Sala dello Stenditoio del Ministero dei Beni Culturali dal presidente Paolo Baratta e dal direttore Daniel Birnbaum, insieme ai due curatori della sezione italiana - Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli - e al direttore generale della Parc, la direzione artistica del Ministero Francesco Prosperetti.
Perché «Fare Mondi» - questo, appunto il titolo dell’esposizione internazionale d’Arte, in programma dal 7 giugno al 22 novembre a Venezia negli spazi dei Giardini dell’Arsenale - vuole mettere al centro della sua riflessione il processo creativo dell’artista, ponendo a confronto alcune figure-chiave dell’arte contemporanea, secondo Birnbaum, con giovani che da essi sono stati ispirati o influenzati. Il giovane curatore svedese non è nuovo alla Biennale Arte, visto che fu a fianco di Francesco Bonami per quella, non fortunata, del 2003 e qui annuncia spazio a tutti i linguaggi e una particolare attenzione alla pittura.
Ma, attenzione, per Birnbaum si deve piuttosto parlare di attitudine pittorica, visto che “pittori” per il direttore della Biennale sono un concettuale come il nostro Michelangelo Pistoletto con i suoi vetri scheggiati, lo statunitense Tony Connor con i suoi schermi vuoti di colori diversi, la tedesca Ulla von Brandeburg con i suoi tessuti o un altro concettuale come il polacco Andrè Cadere con i suoi oggetti colorati. La materia, uno dei valori fondamentali della pittura - al di là della tecnica - viene, evidentemente messa da parte secondo questa concezione critica.
Nulla di nuovo sotto il sole della Biennale, si potrebbe dire, ricordando ad esempio che nel ’91 ricevettero il Leone d’Oro per la Scultura - poi abolito - i coniugi tedeschi Becker per le loro magnifiche fotografie di fabbriche dismesse della Germania Est.
Ma la mostra di Birnbaum, che presenterà una novantina di artisti con molte opere realizzate appositamente per Venezia, sembra seguire da vicino, nella formulazione critica, la Biennale Architettura di Aaron Betsky da poco conclusa. Là si metteva sulla graticola l’architettura “tradizionale” presentando installazione sperimentali della più varia natura, qui si frantumano i linguaggi e la certezza dell’opera, per offrirci di tutto sotto l’etichetta “Arti Visive”: dalle letture di poesia del Moscow Poetry Club, alla parata di Arto Lindsay tra le diverse sedi espositive, dalle attività educational del cinese Xu Tan, alle architetture visionarie del novantenne svedese Yona Friedman.
A noi il compito di credere a questa nuova sperimentalità interdisciplinare, senza porsi troppe domande, ma accettando silenti che artisti pur degnissimi come lo svedese Jan Hafstrom, lo statunitense Gordon Matta-Clark o la brasiliana Lycia Pape siano stati, come ci spiega Birnbaum, tra le “batterie” che hanno trasmesso energia a tutto il movimento artistico contemporaneo e in particolare a molti di quelli selezionati per Venezia 53. Al di là di «Altri mondi», questa edizione della Biennale - nonostante i 2 milioni di euro in meno dallo Stato e un biglietto d’ingresso che salirà a 18 euro - sarà record sotto il piano della partecipazioni dei Paesi stranieri.
Ben 77, oltre la metà dei quali ospitati in palazzi storici, che allargheranno la Mostra a tutta la città. Grande attesa anche per le partecipazioni nazionali tra cui spiccano quelle di Bruce Naumann per gli Stati Uniti, di un pittore-pittore come Miquel Barcelò per la Spagna e di un videoartista come Steve Mcqueen per la Gran Bretagna. La Francia punterà su un artista anch’esso storicizzato come Claude Leveque, con le sue complesse installazioni basate su immagini, suoni e colori e la Germania, a sorpresa, su un artista britannico come il minimalista Liam Gillick.
Riproduzione riservata © La Nuova Venezia
Leggi anche
Video








